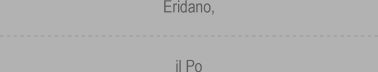Eridano, il Po | Diorama Estate @Pontile B1 Navi Andes, Mantova, 29.06
La quarta tappa di "Eridano, il Po" sarà una lunga navigazione verso il Po. Una "Nave dei Folli" per chiudere con il Diorama Estate quattro stagioni di viaggio in pianura.
ERIDANO, IL PO è una newsletter e un progetto a cura di Piergiorgio Caserini, Luca Boffi e Camilla Romeo.
Eridano è uno dei nomi del fiume Po. Ci è stato detto da un navigante, uno spirito tutelare di queste acque. ERIDANO, IL PO è il titolo del progetto artistico con cui esploreremo le Basse e le sponde tra Pavia, Piacenza, Sorbolo e Mantova, lungo il Po per un anno intero.
Domenica 29 giugno si svolgerà nel letto del fiume, tra le acque del Mincio fino a quelle del Po, il quarto momento pubblico dell’opera “Eridano, il Po”, La Nave dei Folli: un’esperienza collettiva di navigazione, a partire da Mantova con Navi Andes, che vedrà un’intera giornata all’insegna del racconto, del canto e della convivialità. Un ultimo viaggio dentro al fiume che scombina e sostiene questa pianura.
70 posti disponibili.
Ritrovo alle 10:30 al Pontile B1 Navi Andes (Mantova).
Partenza in Battello alle 11:00, durata di circa 5h con pranzo offerto.
Per iscriversi mandare una mail a eridanoilpo@gmail.com con oggetto “PARTECIPAZIONE DIORAMA ESTATE” e il numero di persone.
C’è una circolarità tra ciò che si vede e ciò che si dice, così come esiste tra ciò che si vede e ciò che si fa. Quasi che ogni parola e ogni azione spinga più in là l’orizzonte di visione. D’altronde si sa: vedere è prima di tutto un’esperienza allucinatoria.
Spieghiamoci: non si tratta di dire “pioppo” quando un pioppo capita sotto al tiro dell’occhio ma, per esempio, di contarli. Così che ognuno di loro abbia un numero e un nome, e la loro presenza aumenti. Vertiginosamente aumenta la cattedrale ordinata, così come la legna che un domani saranno. Similmente non si tratta di vedere le polle degli acquitrini, ma di sapere che milioni di lemne la tappetano fuori stagione, e che soltanto dopo averci immerso i piedi si potrà dire della consistenza del suolo là sotto. Il tocco del fango dà voce e parola al fango. Così vale nel saper nominare l’aria del Favonio, e sapere allora che nonostante il caldo, le api e i fiori, che questo vento porta, la primavera è falsa, ancora lontana. La parola, insomma, fa spazio quando vuole. Saggia quel che trova, s’inoltra, lo percorre e lo spalanca. Quando pare che nulla ci sia più da vedere, quando si è stanchi di non vedere più niente, parole e azioni sono esercizi percettivi d’esagerazione, di drammatizzazione. Aprono, spalancano tutto.
Altrove scrissi che ci sono numi in tutte le cose. Nominarle è complesso. Sono vaghe presenze, sensazione d’un qualcosa – ricordo una bella frase di Celati: «Essere guidati da ciò che chiama» –, e per far sì ch’esistano e che assumano un segno, che dicano o indichino, bisogna esercitarsi a riconoscerle. Allora un paesaggio s’attenziona, si ravviva di presenze e potenze. Sono esemplarità, numi. Indicano una via d’accesso a un luogo, un picco di senso, una vertigine.
Eridano è questo. Un trovare le ricorrenze d’un paesaggio per imparare a vederlo, senza ch’esso passi in sottecchi. Tornare, ricorrere, ripetere: far sì che sempre qualcosa ritorni perché non scompaia nel nulla – un tornare alle cose, come scrisse Luca qualche anno fa nei testi di Caro Campo. Abbiamo fatto tre Diorami finora, e ognuno di questi, l’Autunno, l’Inverno, e la Primavera, non volevano nient’altro che questo. Fare spazio, vedere un paesaggio che per natura sua – monotonia, piattezza, lontananza, ordinarietà – sfugge all’attenzione. È così che la pianura si nasconde, si fa sfondo.
Camminando in autunno in lungo e in largo, nella nebbia e negli scanni di sabbia chiara, abbiamo descritto ciò che c’era con noi, ciò che “chiamava” – e descrivere, elencare, riportare quanto c’è è uno dei tanti modi per non lasciarsi sfuggire cose e fenomeni nell’indistinto dello sfondo. Dare rilievo a un’esperienza, intensificarla. Avendo intonato in inverno il canto onomatopeico degli uccelli, sappiamo ora riconoscere chi svolazza tra il turchese esploso del cielo e nelle ombre delle frasche golenali. Conosciamo i loro nomi. Nascondendoci in primavera nell’acqua esondata tra i pioppeti, correndo nei solchi delle lanche e nei campi brulli, abbiamo giocato col fiume, con l’erba e coi sassi, imparando che dietro ognuno di loro c’erano ruspe e cantieri. In ogni stagione s’è costruita una presenza, e un paesaggio s’è svegliato dal sonno.
È Estate, ed Eridano giunge quasi al termine. Il quarto Diorama sarà il nostro ultimo incontro prima dello spettacolo finale di settembre, e faremo un viaggio in nave per raggiungere il Po. Un’ultima navigazione per trovarci nel fiume, dentro alle sue sponde, in quell’Eridano che, come ci raccontò quel navigante che è Giuliano Negrini di Navi Andes, è il luogo del mito di Fetonte.
La storia è raccontata nelle Metamorfosi di Ovidio, e racconta di come Fetonte, figlio del Sole e dell’oceanina Climene, rovinò la terra tutta, finendo per modellare il paesaggio del Po per come lo conosciamo. Con vanità inizia questo mito, con Fetonte sfidato a dar prova della propria discendenza divina. Con orgoglio inizia la catastrofe, quando le parole del Radioso, che l’accolse come figlio, non furono sufficienti a Fetonte. Egli esigette una prova: guidare il carro del Sole. A nulla bastarono gli avvertimenti e le precauzioni, a niente servì il racconto dell’altezza vertiginosa e della forza indomabile dei quattro cavalli di fuoco. Al padre divino non restò che accettare. Depose allora olio sul viso del figlio, perché non si bruciasse. Gli indicò il sentiero nel cielo, scavato dal ripasso giornaliero della luce del Sole. L’avvisò di stare lontano dal Granchio che serra le chele, dal Leone che ruggisce feroce. Di non volare né troppo basso né troppo alto, perché terra e cielo, umani e Celesti, non rischiassero di bruciare. Quando Teti, la luna, aprì i suoi cancelli, Fetonte imbroccò avventato le briglie, e strigliando i cavalli si lanciò sul ripido crinale della volta. Ma il peso sulla biga era poco, e i quattro cavalli capirono. Liberatisi dal morso s’imbizzarrirono, e Fetonte prese spavento: per la furia di quelle bestie, per l’orrore delle creature disegnate dalle stelle, per l’altezza tremenda. Si coprì gli occhi, e senza controllo il Sole impazzì. Bruciò la terra, bruciarono i boschi, i fiumi e i mari, si spogliarono i monti e s’aprirono deserti. La Terra strillò insopportabilmente. Allora giunse il giudizio risolutivo del Cronide, quell’unica legge che fa destino. Con un colpo Zeus uccise Fetonte, nell’unico episodio in cui una saetta si scaglia a ciel sereno. Dall’alto cadde il suo corpo, rovinando nell’Eridano, e tanto bruciava da far evaporare l’acqua del fiume – nascita possibile della nebbia. Alla sua morte, le sorelle Fetusa e Lampezia lo piansero, e qualche altro dio le coprì di corteccia: diventarono pioppi – nascita possibile delle golene. Un amico e amante, Cicno, Re del popolo dei Liguri, piangendolo per quattro lune verrà misteriosamente metamorfosato in cigno – nascita possibile del magone, l’irrisolutezza della perdita. E anche quando gli Argonauti passeranno per l’Eridano, tra nebbia, fumi e miasmi, riconosceranno il corpo di Fetonte ancora intento a bruciare sul fondo del Po, e di fronte, sempre, le sue sorelle e il suo amico.
Fiume, acquitrini, lingue d’acqua morta, pioppi, scanni e golene, secche e alluvioni: ci sono numi in tutte le cose, presenze che sopravvivono nel loro ricorrere. Attendono d’essere viste, svegliate. Ma vanno cercate, trovate sempre e ancora. Per questo i Diorami, per questo l’opera in movimento, per questo i racconti. Perché aneddoti, storie, narrazioni, azioni e parole rivolte al paesaggio fanno spazio, e trovano sempre qualcuno o qualcosa.
Durante la navigazione verso il Po di domenica 29 giugno metteremo in scena una visione – che, come ogni visione, ha sempre un qualcosa di allucinatorio. Sarà una matàna, un giusto delirio che è un mito, una leggenda, un coro. Una nave di folli che saprà vedere numi in tutte le cose, che parlerà coi cieli e coi fiumi, coi boschi e le foglie. Che saprà come nella lucciola che muore giorno dopo giorno ci sia un destino comune, uno sparire. Che niente di ciò che è stato sarà più, e non c’è nostalgia in questo. Che nei grandi temporali, nelle grandinate, nelle trombe d’aria che scoperchiano i tetti c’è un’altra terra, e parla la lingua dell’inimicizia. Che negli occhi dei pioppi vedrà il pianto di due sorelle, nella nebbia un corpo che brucia, nel cigno che gironzola tra le petecchie palustri un lamento che non ha mai smesso di dipingersi sugli occhi della bestia. Nelle bestie, nei fiumi e nei cieli qualcosa di noi. Si piange ciò che non torna, ma si deve sorride a ciò che sempre, seppur diversamente, ricorre e continua a parlare.