Eridano, il Po | Diorama Primavera @Riserva Naturale Orientata della Parma Morta, Sorbolo Mezzani, 31.05
La Primavera è iniziata da un po', e finalmente faremo la terza e penultima tappa di "Eridano, il Po". Un esercizio di dialogo intimo con il paesaggio golenale della Riserva rinaturata.
ERIDANO, IL PO è una newsletter e un progetto a cura di Piergiorgio Caserini, Luca Boffi e Camilla Romeo.
Eridano è uno dei nomi del fiume Po. Ci è stato detto da un navigante, uno spirito tutelare di queste acque. ERIDANO, IL PO è il titolo del progetto artistico con cui esploreremo le Basse e le sponde tra Pavia, Piacenza, Sorbolo e Mantova, lungo il Po per un anno intero.
Sabato 31 maggio si svolgerà nella Riserva Naturale Orientata della Parma Morta, in provincia di Sorbolo Mezzani, Nascosti tra le erbacce: il terzo momento pubblico dell’opera “Eridano, il Po”. Il workshop relazionale vedrà una serie di azioni di compagnia, un tributo al gioco di una giornata intera tra le aree golenali rinaturate nei pressi della nuova lanca, in collaborazione con il Comune di Sorbolo Mezzani, la fotografa Francesca Marengo e con il patrocino di Parchi del Ducato.
12 posti disponibili.
Per iscriversi mandare una mail a eridanoilpo@gmail.com con oggetto “PARTECIPAZIONE DIORAMA PRIMAVERA” e il numero di persone.
Il ritrovo è alle 10:30 in stazione FS a Parma. Da lì, ci sposteremo per raggiungere Sorbolo Mezzani e la Riserva, dove cominceremo il workshop. Il pranzo sarà al sacco, e staremo assieme fino alle 17:00 circa.
Attraverso una serie di esercizi svolti in una dimensione di gioco e di scambio, i partecipanti sono incoraggiati a stabilire un dialogo intimo e attivo con un luogo della Riserva rinaturata; si lavorerà con il corpo, si utilizzeranno tessuti, elementi naturali come fango, rami e sassi di fiume.
Recuperare una semplicità primordiale, ridurre, imparare a lavorare con il vuoto. / Sentirsi liberi di fallire e ricominciare. Esplorate, vagate, rafforzate i vostri sensi. Identificarsi. / Stabilirsi. Scegliere il proprio luogo, prendersene cura. / Documentare. Date forma alla vostra narrazione. Modificate il vostro spazio temporaneamente, trasformate anche voi stessi.
Luca
Siamo tornati di nuovo a Sorbolo Mezzani, alla Riserva Orientata della Parma Morta. A metà aprile i pioppeti sono spariti, la lanca è stata scavata. Il taglio tecnico e trapezoidale che a settembre era bruno di fango ora è spazzolato da guance d’erba giovane e turgida. Rivolgendo lo sguardo a Ovest non se ne vede la fine, il solco procede curvando dietro una golena, ma appena dietro di noi l’acqua del Po lecca la riva: una grande spianata di terra nuda, di quel bruno che non ha mai visto il sole.
Due ruspe, in lontananza, lavorano ancora per abbassare la sponda. Il fiume aspetta che quell’ultimo atto del cantiere finisca. Resta ancora un ponte di terra da abbattere nello scavo della lanca, un muro largo quel tanto che basta per far passare ancora una volta le escavatrici. Quando l’acqua arriverà, la parete sarà costretta a gonfiarsi, a bucarsi in fontanili, e infine a cedere in bave di fango. In men che non si dica, o comunque più sveltamente di quanto si immagini, quel solco vuoto sarà un braccio di fiume.
Arriverà con le piene, ci siamo detti. E poi le piene sono arrivate, a Pasqua. Ai Morti della Porchera l’acqua è salita tanto da entrare nel portico, e il canale della Mortizza non aveva più riva. Alla Confluenza Ticino-Po ha piegato una radura intera, alzando il suolo di almeno cinquanta centimetri. Una vagonata di sabbia, canneti coperti dal fango, cataste disordinate di tronchi divelti.
Proprio sulla riva, affianco allo scavo della lanca, ci sono dei greti artificiali, mai visti. Cumuli lineari di sassi grandi e bianchi come la calce, di quelli che ci s’aspetta di trovare su un lungomare. Formano un argine temporaneo, un terrapieno di pietre: è la sponda incaricata di spezzare il fiume alla prima piena, alta quel tanto che basta per incanalare l’acqua senza che travasi. Non sappiamo ancora se qui il Po s’è spezzato. Non sappiamo dunque se quello spazio ritagliato dalla lanca sia finalmente diventato un’isola, una golena derelitta abbarbicata a uno scanno, separata da tutto, una riserva. Non sappiamo ancora, insomma, se l’esondazione del fiume ha terminato il cantiere delle ruspe.
Rinaturare: così si chiamano queste operazioni in cui boschi e fiumi vengono messi in cantiere. Sono azioni riparative, e allo stesso tempo dei lasciti, poiché i boschi e i fiumi andranno poi da sé, accoglieranno le specie che vorranno, e s’integreranno via via nell’ecosistema locale. Prima o poi, saranno indistinti: si vedrà un bosco, e non più un cantiere. La natura è un’intenzione ben camuffata da queste parti. Edificata da ruspe e cresciuta in foglie ed erba e alberi e rogge.
Rinaturare: ricordare l’evidenza che qui tutto il paesaggio è l’esito d’un lavoro tecnico, d’un progetto, d’una visione. Per molte persone, queste operazioni sono ambigue. Feriscono un’idea di “autenticità”, di qualcosa da tutelare per come si tutelano i bambini. D’innocente e intoccabile, di qualcosa che va salvato dal mondo, e che dovrebbe invece procedere da sé. Ma il bosco crescerà. Il fiume si riempirà. La golena verrà allora abitata da un popolo che oggi ancora non c’è, e il frastuono sarà tanto che nessuno ricorderà più quel cantiere.
Si può vedere, quest’esito. Non distante dalla lanca c’è una piccola riserva. Sono due laghetti conchiusi in una cittadella di frasche, invisibili. Ci si passa affianco sulla strada arginale, ma tutto ciò che si vede sono pareti d’alberi. Ci si passa affianco passeggiando sui sentieri d’erba, dove esili pioppi e olmi sono stati piantati da poco, e si trovano uova bianche e azzurre frantumate a terra. Qualcuno le ha lasciate cascare dal cielo, pensiamo. Alziamo gli occhi e vediamo: nel cielo spazzolato dai rami oltre al muro di frasche ci sono decine e decine di garzaie.
Dobbiamo insistere un poco per trovare un passaggio. C’infraschiamo nel muro di foglie, e ci troviamo su una stretta e lunga sporgenza di terra fangosa, umida e morbida. L’odore è quello d’acqua stagnante e merda di uccello, che effettivamente punteggia l’erba, il fango e i rami. Ancora uova aperte, frantumate, come se qualcuno ci avesse infilato un dito o un becco. Attorno a noi un laghetto acquitrinoso circonda come un fossato questa lingua fangosa, larga appena un paio di metri.
Ora li vediamo: decine e decine di nidi, l’aria che freme degli strilli di nitticore, aironi cinerini, gallinelle d’acqua e cavalieri d’Italia. Non c’è modo di contarli. Troppi uccelli, troppe garzaie. Si percepisce tutto sommariamente, per grandi insiemi. C’è allora la generalità delle centinaia, la generalità dei bianchi, degli strilli e dei versi, quella dei rami e delle tante uova aperte e sbriciolate a terra. Il paesaggio è affollato, e noi restiamo siamo nascosti, immobili. Li ascoltiamo e li guardiamo, come si ascolta e guarda qualcosa che non andrebbe visto. Ci facciamo piccoli e silenziosi, con passo da chiesa c’inoltriamo e ci fermiamo nel mezzo. Un pesce salta, uno stormo di nitticore si sposta di qualche ramo, un airone cinerino, immobile sopra di noi, volta il becco in direzione delle uova. Ci hanno visto, ma non siamo di disturbo. Capiscono forse che non c’è alcuna intenzione se non quella d’ascoltare e guardare, e dunque continuano come se niente fosse, come se fossimo alberi piantati su quella lingua di terra impastata dall’acquitrino. Come se fossimo, penso. Come se fossimo: è con questo pensiero che si popola tutto un paesaggio.

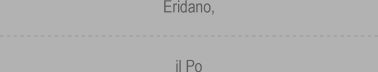






Incanta questa narrazione del Grande Fiume, come creatura vivente,
come un amico cui prestare attenzione, ascolto,
lungo il quale mettersi in cammino, trovare riparo.
Stare.
"Come se fossimo", appunto.