Eridano, il Po | Voci di Bestie del Cielo
La storia dell'imbarcadero ai Morti della Porchera e dell'immedesimazione con l'avifauna locale nel Diorama Inverno, la seconda tappa del progetto "Eridano, il Po".
ERIDANO, IL PO è una newsletter a cura di Piergiorgio Caserini, Luca Boffi e Camilla Romeo.
Eridano è uno dei nomi del fiume Po. Ci è stato detto da un navigante, uno spirito tutelare di queste acque. ERIDANO, IL PO è il titolo del progetto artistico con cui esploreremo le Basse e le sponde tra Pavia, Piacenza, Sorbolo e Mantova, lungo il Po per un anno intero.
In queste newsletters leggerete delle ricerche e dei metodi che accompagneranno questo viaggio, e inevitabilmente troverete le storie dei luoghi, personaggi reali e verosimili, racconti popolari, feste e fisime che accompagnano queste terre.
Fin da bambini s’impara che la pianura esiste soltanto perché c’è stata l’acqua. Sicché, quando ci si avvicina al Po, si finisce puntualmente per provare una certa reverenza: ci si fida del fiume, ma se ne conoscono assieme le bizze, i capricci e le ritorsioni. Si apprende presto ad avere a che fare con le alluvioni, un po’ dopo con le secche e la siccità. Poi vengono gli scavernamenti del suolo, e dopo ancora il crollo dei ponti. Ricordo quando una piena vigorosa strappò via due piloni al ponte di Piacenza, facendone rovinare in acqua un segmento consistente. Al suo posto misero un ponte di barche, piatto e a fior d’acqua, su cui si sentiva tutto lo scrosciare del fiume all’ombra del ponte derelitto. Da qui, guardando a est, il Po curva repentinamente a sinistra, e subito s’annoda frettoloso attorno a una lingua di terra che è tutta pioppi e olmi, una golena davanti alla quale c’è lo Chalet Fiume Po, più comunemente noto a chi lo conosce come “I Morti della Porchera”.
Il nome dell’imbarcadero in questione, che è una trattoria, una vecchia balera, insomma un punto di ristoro, rabbocca due storie. I morti sono soldati spagnoli vittime della peste alla fine del Settecento – qualcuno dice anche soldati ungheresi –, interrati in un cimitero di cui ormai più nulla si vede, nei pressi di un sacello, perduto anche questo, intitolato a San Michele. Fecero miracoli, questi spettri, pregati per sanare ciechi e malfermi, seppur non sia ben chiaro se furono i cadaveri dei soldati o la stessa figura del Santo, visto volare sulle acque limacciose durante una grande piena il secolo successivo, a concedere le guarigioni.
Eppure ho visto la figura del Michele processata sulle acque del Po o sull’argine maestro, sia durante quella che fu la tradizionale festa a settembre, sia quando il fiume minacciava d’esondare e le campane suonavano a martello. Per modo di dire, io lì ci sono cresciuto: da bambino, da adolescente, da adulto, tutt’oggi. Tant’è che il Mino, proprietario storico dei Morti, lo saluto in dialetto, come del resto fan tutti. Considero questo paesaggio uno di quelli che hanno configurato una mia esperienza del vedere, una maniera o uno stile, ed è per questo che una volta, altrove, scrissi che per me il Po non può che cominciare da qui e non dal Monviso, che non si vede nemmeno da lontano.
È un luogo verso cui ho un debito e una riconoscenza, grazie al quale ho appreso a osservare in un modo piuttosto che un altro, in cui mi sono per certi aspetti formato. Sarà per questo che in questo scampolo di paesaggio mi è sempre parso di trovarci un po’ tutta la pianura fluviale, quasi che fosse una miniatura. Un diorama che comincia con le belle colline cineree delle cave, che son bianche come le ossa, alti cumuli di ciottoli e sabbia ben ammucchiati per il viavai dei camion. Con le larghe golene di pioppi, montate come se il bosco fosse una cattedrale, per decine e decine di navate ombrose. Si vedono i porticcioli grandi e quelli piccoli, le lance da amatori, i motoscafi e le chiatte piane dei pescatori. C’è l’attracco in metallo del Ligaligò, un battello da crociera blues abbandonato dopo pochi anni d’attività, e il grande canale colatore della Mortizza, che prende le acque di risorgiva del Brembiolo e s’infila nel fianco del Po dritto come un righello. Qui, durante le secche, ho visto scanni di sabbia stringere il letto del fiume e farsi golena in qualche mese. Un bosco nasceva timido da una spiaggia. Le ho viste sparire durante le piene, e ho incontrato un’acqua limacciosa intenta a leccare gli scalini del portico e i piedi dei presenti, tutti consci di quella vecchia tacca nera sul comignolo, lasciata lì a rammemorare una piena disastrosa.
Che sia estate o inverno, qui si trova sempre qualcuno. Si beve vino rosso e pesante, birre scelte da Mino, salame tagliato come si deve – vale a dire spesso, perché «La fetta di salame deve stare in piedi» –, polenta e alborelle fritte. C’è chi fa karaoke sui piccoli motoscafi, chi gioca a carte e bestemmia, ma rivolgendo l’attenzione al di fuori del locale si può ascoltare tutto quello che si vede: il rigurgito dell’acqua e la corrente, il lavorio delle cave e il fruscio delle foglie, i ciclisti sull’argine e i parlottare degli uccelli, che s’infrascano tra le golene derelitte sfrecciando tra i rami freddi d’inverno e nascondendosi tra le foglie gonfie d’estate. Difficile vederli, anche dove s’aprono i corridoi dei pioppi. C’è però una coppia di ontani che s’aggetta sull’acqua dal terrapieno, nella lunga golena appena oltre la Mortizza. Al calare del sole, ogni volta, decine di uccelli, forse nitticore, vi s’appollaiano immobili e strillano. Salutano il giorno che fugge, e sono come petecchie bianche che s’alzano turgide sul livido bruno dei rami.
In un pomeriggio di inizio febbraio, appena dopo i giorni della Merla e con un sole che già scuote il calore dei mesi che verranno, ci siamo ritrovati in una trentina sulle due sponde del canale della Mortizza. Ognuno, nei giorni precedenti, ha avuto modo di scegliere un volatile. Che l’abbia scelto per bellezza, affinità o richiamo non importa. La richiesta era semplice: costruire un canto corale per popolare un paesaggio ombroso, quello della golena, che non si dà aprico allo sguardo, come il resto della pianura, e che a vedersi sembra un vuoto di verdi. La settimana prima, in due lezioni tenute da Simone Ravara, abbiamo imparato le onomatopee dei versi, le movenze e le abitudini. Il giorno stesso, ai Morti, abbiamo tutti cantato liberamente l’uccello che c’eravamo assegnati, seguendo una notazione scritta appositamente da Francesco Fusaro. Per una mezz’ora la Mortizza e il Po non hanno avuto stagioni. C’erano le bestie dell’inverno e quelle estive, quelle svernanti e sedentarie, e c’erano dunque l’allodola e l’assiolo, le gru e gli aironi, i picchi e le cicogne e i tarabusi, e avevano capelli biondi, ricci, lunghi e castani, barbe arruffate e baffi e cappelli e occhiali da sole, quasi tutte con verdi stivali di gomma. La terra, ammorbata dalle piogge della settimana, mangiava i piedi a tutti.
Così abbiamo deciso di fare paesaggio quest’inverno. Con un canto che ha evocato le bestie assenti e presenti, quelle sparite e quelle a venire. C’erano versi storti e inesatti, altri strabilianti e similissimi. Si sarebbe potuto pensare che si cantasse il lutto di quel che è svanito, e che proprio per questo risultasse rotto, raffazzonato, perché ciò che è perso è impossibile che ritorni. Ma anche che così facendo si facesse invece un memoriale, evocando la presenza di chi è già fuggito. Ma non ci importa che sia vera l’una o l’altra o addirittura entrambe. Quel che valeva era il gioco dell’approssimazione – quello che, come vi abbiamo raccontato, fece a sua volta fece Ligabue –, e il dichiarare una presenza. La loro e la nostra.
Siamo stati come bestie del cielo, e apprendendo l’onomatopea di quei versi e quelle lallazioni, quei battiti quegli strilli e quei grugni, s’è popolato un paesaggio. Qualcosa non c’era, eppure se fatta presenza. Ora si sa. Si sa chi c’è d’inverno e chi d’estate, chi di notte e chi di passaggio. Ora si riconoscono, e saper che ci sono e saperli chiamare, anche se privi d’esattezza, è arricchire la percezione di un luogo.
Abbiamo dunque guardato il cielo, passato la Mortizza, corso nel fango, setacciando qua e là gli azzurri e i verdi di quella giornata, chi in cerca di una risposta, chi immaginando come sarebbe versificare là in alto, chi s’è inalberato e chi ha danzato. Così abbiamo imbastito uno spazio pensoso. Abbiamo riaperto quella visione che comincia dalle cave, dal fiume, dalle golene, e l’abbiamo riempita di bestie del cielo, ricordandoci che il paesaggio non comincia soltanto dove la vista si sostiene all’evidenza, ma anche là dove si cerca al buio, nel nascosto, qualcosa che non c’è e alla fine lo si trova.
Questi sono due estratti di quella trentina di bestie del cielo che siamo stati quel pomeriggio, intenti a cantare per stormi a passeggio da una sponda all’altra della Mortizza.
Piergiorgio
Un esercizio
Cannareccione: CRIE CRIE TRR TRR CHIE CHIE CRA CRA
Cavaliere d’Italia: KII-K KII-K KII-K KII-K
Cicogna Bianca: TA TA TA TA TA TA TA TA
Cuculo: CUCÙ CUCÙ CUCÙ
Gruccione: QUI QUI QUI QUI QUI
Pigliamosche: SSSI-CIÉ SSSI-CIÉ
Quaglia: BIU BIU IU BIU BIU IU
Rigogolo: FOO-FLIUO-FIII-FIIIU, FOFLIUU-FIUO FIIUU
Torcicollo: TIE TIE TIE TIE TIE TIE TIE TIE TIE TIE TIE TIE
Upupa: UP-UP-UP UP-UP-UP
Cesena: CIAC-CIAC-CIAC-CIAC-CIAC, CI-CI CIAC-CIAC-CIAC-CIAC CIAC CI-CI
Fischione: VUII-U VUII-U VUII-U
Gru: KRUU-Ù KRUU-Ù
Luì Piccolo: UUÌ UUÌ UUÌ
Pavoncella: PWII-ÌÌ PWII-ÌÌ
Tarabuso: HUU-Ù HUU- Ù
Allocco: HUUU U HU HU HUUU U
Assiolo: CHIU-I CHIU-I CHIU-I
Barbagianni: SHRIIIIII SHRIIIII
Civetta: CUCU-BIU CUCCU-BIU
Gufo Comune: UUUH UUUUH UUUUH
Occhione: KLIUURR-LÌÌ KLIUURR-LÌÌ
Succiacapre: RRRRRREREEEEERRREEE RRRRRRROOOOOREEEEE EEEERRRROOOORRRREE
Colombaccio: HU-HUUU-HUU HUHU, HU-HUUU-HUU HUHU
Fringuello: ZITT-ZITT-SETT-SETT-SETT-CIATT-CITERIIDIA
Germano Reale: QUE-QUE-QUE-QUE-QUE QUE-QUE-QUE-QUE-QUE
Martin Pescatore: ZZZ-ZIII ZII-TII ZZZ-ZII
Picchio Rosso Maggiore: TE TE TE TE TE TE
Picchio Verde: CHIIU-CHIIU-CHIIU-CHIIU-CHIIU-CHIIU-CHIIA-CHIIA
Porciglione: GRUII GROOO GRUUI GRU OOOUIII

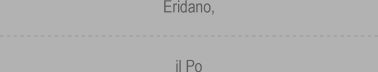


Fantastico! Vi siete divertiti come pazzi, ritrovando l'armonia e la straordinaria bellezza del fiume ebbro di musica e poesia.
Mi sarebbe piaciuto esserci. 💚